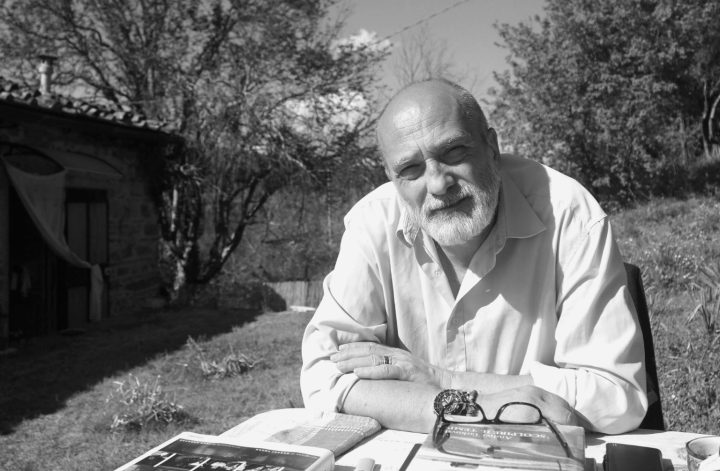Nel 2019 usciva Dimora (Itaca Edizioni) a cura di François-Xavier Bellamy, insegnante, filosofo e politico francese membro del Parlamento Europeo, un libro che a rileggerlo oggi sembra anticipare tante riflessioni emerse con la pandemia che sarebbe esplosa di lì a poco. Dilemmi che vivono in noi come ferite aperte per questo recente passato e come ipoteca sul presente che minaccia il futuro. Riprendere oggi il libro può aiutare a capire chi siamo e a definire le sfide che ci aspettano.
In «Dimora» lei spiega che si afferma oggi una nuova concezione antropologica in basse alla quale all’uomo non sarebbe concessa altra azione che quella di partire. Nel frattempo è arrivata la pandemia e siamo stati costretti per lunghi mesi in casa. Che effetto ha avuto questo immobilismo sulle persone?
La quarantena è stata un’esperienza piuttosto sorprendente per me. Siamo stati d’un tratto “assegnati a dimora” e, in un certo senso, il movimento perpetuo si è fermato. Alcuni hanno sperato in un mondo “altro”, in un mondo del “dopo”, un mondo nel quale saremmo stati finalmente meno sedotti dall’attivismo, nel quale avremmo avuto più tempo per viverlo, questo mondo, per abitarlo; altri l’hanno vissuta come una vera e propria prova. Quel che è incontestabile, credo, è che quest’esperienza ha rivelato il carattere superfluo di molte delle nostre agitazioni, e che non ritorneremo più del tutto alla vita di prima.
Forse il disagio che abbiamo provato ha a che fare con lo sperimentare un ultimo vuoto esistenziale?
Il “divertimento pascaliano” rimane una tentazione eterna, quella di voler “fuggire se stessi”; ma mi pare che la modernità aggiunga una dimensione supplementare, nella misura in cui il movimento diventa un obiettivo in sé, un valore; ciò implica che il luogo in cui ci troviamo è necessariamente meno valido di quello in cui potremmo essere. In questo senso, la peggiore fuga dal presente è forse quella che chiamiamo ottimismo — sembrerà paradossale. Mi riferisco a quell’ottimismo generale che consiste nel dire che «il domani sarà per forza migliore dell’oggi»: vi è qui il nodo del progressismo, che non descrive la volontà di fare dei progressi, ma l’idea che ogni cambiamento sia necessariamente progresso.
Il dibattito tra movimento e stasi risale all’epoca dei filosofi greci. Qualcosa si è rotto in seguito?
In fondo, non è altro che il grande dibattito di Parmenide e Eraclito che ancora continua. Questo dibattito si risolse al tempo con l’equilibrio creato dalla soluzione aristotelica: la meravigliosa ed elegante soluzione metafisica della potenza e dell’azione, l’idea che il divenire è il compimento di qualcosa che vuole realizzarsi — e questa soluzione aristotelica è rimasta il paradigma incontestato fino alla fine dell’Età classica. La Modernità è la nuova configurazione del pensiero che dà al movimento il valore assoluto. Il grande interrogativo è: che cosa ha costituito questo ribaltamento nella Modernità? Cosa ci ha fatti entrare nella Modernità? Una risposta semplice sarebbe la scienza, e quindi Galileo, che infatti non scopre soltanto che il sole è il centro del sistema dei pianeti, ma che la Terra gira e che, proprio perché gira, ogni cosa che crediamo immobile è in realtà anch’essa in movimento.
Le sue scoperte diedero origine a una serie di conseguenze che portarono alla graduale perdita di punti di riferimento prima intoccabili. Ma Galileo aveva ragione. Allora qual è stato l’errore?
Fino ad allora la matematica era un esercizio intellettuale totalmente slegato dalla realtà fisica. Tutto a un tratto Galileo scoprì che i calcoli di Copernico (basati sul presupposto che il sole è il centro del sistema solare) non solo erano più efficaci nel prevedere la posizione delle stelle, ma dicevano anche la verità sull’Universo, e cioè che l’Universo è scritto in numeri — che i numeri sono, in un certo senso, il linguaggio di Dio. È questa la prospettiva che accompagna Cartesio: il progetto della matesis universalis preannuncia il progetto contemporaneo del big data e dell’intelligenza artificiale, ovvero il progetto di trasformare tutta la realtà in numeri e, a partire dai numeri, tutta la conoscenza in potere. «L’universo è scritto in linguaggio matematico», scrisse Galileo ne Il Saggiatore. Questo è, da un punto di vista scientifico, assolutamente vero; abbiamo solo perso l’umiltà necessaria per riconoscere che la scienza non ci dice tutto della realtà, che l’universo fisico è certamente in movimento, ma che noi abitiamo un universo spirituale, che è fatto di punti di riferimento.
Lei sostiene che la politica oggi si è ridotta a «semplice gestione del cambiamento». Com’è possibile recuperare il senso vero e profondo della sua missione?
Ciò che mi colpisce al Parlamento Europeo (e non ne ero membro quando ho scritto il libro) è proprio questo: non vi è dibattito sulle finalità. L’unica preoccupazione è gestire ciò che viene descritto come ineluttabile. Mi sembra che ci siano qui due problemi: il primo è che questo è il segno di un indebolimento delle nostre società — pensiamo che il futuro sia scritto e che non resti che adattarcisi, che sia necessario avanzare perché il mondo avanza, che occorra stare al passo con il ritmo che il mondo ci impone. Il secondo problema che vedo è che, se non sono ammesse alternative, non vi è più un vero dialogo. La politica è necessaria perché bisogna fare una scelta, perché la direzione da seguire non è evidente. La domanda che dovremmo porci non è se bisogna avanzare o no, ma verso quale direzione, qual è il nostro obiettivo. È qui che inizia la politica.
«Resilienza» sembra essere la nuova parola d’ordine. Essa rischia di precludere l’esperienza di una conoscenza critica?
L’epidemia ci ha rivelato che di fronte al rischio della morte eravamo pronti a fermare tutto; non lo critico, è un fatto. Siamo oramai parte di un mondo con così poca resilienza che sperimentiamo tutti una specie di panico di fronte al rischio della morte. È incontestabile che la vita umana abbia un valore assoluto; fa parte delle finalità che dobbiamo servire, ed è l’onore di una società fare di tutto per preservarla. Ma vi è qui un problema che interroga la nostra resilienza, appunto: in che misura la libertà è rimasta per noi un fine, una finalità non negoziabile? Teniamo solamente alla vita nuda, alla vita organica, alla vita biologica, oppure siamo capaci di accettare l’avventura di una vita data per qualcosa di più grande di lei? Se dovessi trovare, in tal senso, una ragione molto umana, profondamente legata all’esperienza, di una verità del Vangelo, sarebbe la formula di Cristo che dice: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà».
L’ultima grande sfida sembra essere proprio quella della morte. Non è quindi un caso che in «Dimora» lei faccia riferimento al concetto di sostituzione piuttosto che di cura. Che cosa significherebbe per la società se non dovessimo più morire?
Significherebbe innanzitutto che nessuno debba più nascere! Altrimenti avremmo presto un problema notevole. Ha ragione, la volontà di trasformare tutto raggiunge oggi il suo ultimo limite: l’uomo stesso. Se niente più ci soddisfa, ci convince nel reale, l’uomo stesso deve essere trasformato. Il sogno del Transumanesimo non è che il progetto di questo cambiamento applicato all’autore stesso del cambiamento: si tratta di superare i confini che limitano il suo movimento, di eliminare le rigidità, i pesi della vita umana. I due grandi confini che stiamo cercando di superare sono quelli che lo hanno messo alla prova fin dalla notte dei tempi: il sesso, e la morte. Il sesso perché l’alterità sessuale fa sì che non posso essere, io solo, il “tutto” dell’Umanità, che non posso dare la vita da solo. Il secondo bersaglio è la morte — non si tratta più di respingerla con la medicina, bisogna abolire la morte organica, la morte del corpo. Questa speranza di progresso è in realtà solo il sintomo del disprezzo che esprimiamo per l’essere umano. Aggiungerei che la guerra dell’uomo contro l’umano che è il Transumanesimo è destinata al fallimento, perché non finirà mai. Se non abbiamo più un obiettivo certo da raggiungere, non potremo che essere, sempre, strutturalmente insoddisfatti del punto in cui siamo arrivati. La tecnologia sostituisce continuamente i propri prodotti e crea, così, un’insoddisfazione strutturale; lo stesso avverrà per l’umano. Non ne avremo mai abbastanza, non saremo mai appagati, e non sapremo più abitare l’esperienza che ci è stata data. La grande questione politica dei prossimi decenni non è altro, in fondo, che la più grande questione spirituale che l’uomo sia mai stato chiamato a risolvere: vogliamo imporre alla realtà la nostra volontà di potere, e tentare di trasformare sempre tutto in cambio di una frustrazione continua, impossibile da colmare; o vogliamo accettare di ricevere da ciò che ci precede quel che merita di essere trasmesso, quel che merita di rimanere, e che chiede il nostro stupore?
Alessandro Vergni
Articolo pubblicato su L’Osservatore Romano del 14 gennaio 2022 – traduzione a cura di Ottavia Pojaghi Bettoni